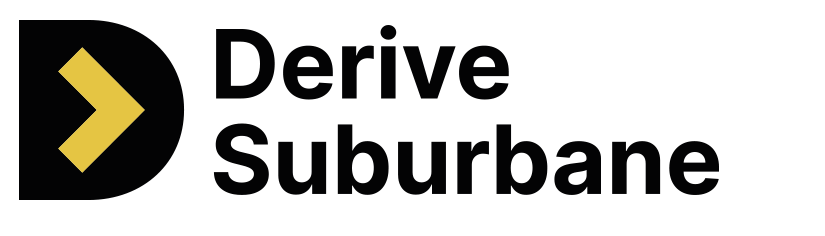Rispetto ai padiglioni storici della Mostra d’Oltremare che abbiamo raccontato in precedenza, relitti abbandonati e consunti che invocano pietà per lo stato di degrado in cui versano (v. link in basso), l’area che circonda il laghetto Fasilides e fiancheggia il Parco Robinson ha tutta l’atmosfera di un rilassante e silenzioso spazio verde, nel cui perimetro riposano edifici dall’apparenza di antichi resti archeologici. Si tratta della chiesa copta e del Castello di Gondar, imitazioni fedeli dell’architettura etiope inserite nella sezione della Mostra dedicata all’Africa Orientale, nella quale erano compresi il Cubo d’Oro e altri sette padiglioni.
IL CASTELLO – Nella nostra deriva, ci è sembrato di uscire del tutto dall’habitat urbano e fare ingresso in uno scenario bucolico, quasi fiabesco. Tanto più considerando che la prima apparizione è stata il Castello di Gondar, un castelletto sospeso su una superficie d’acqua e circondato da prati sui quali si aggirano o sonnecchiano stormi di tacchini neri (da qualche parte dovrebbero nascondersi anche esemplari protetti di rospo smeraldino). La cospicua popolazione animale e la fontana a getto alternato installata sott’acqua conferiscono al laghetto Fasilides le sembianze di un piccolo parchetto archeologico ben curato, dove isolarsi e cercare quiete.
Quest’area della Mostra d’Oltremare fu concepita, nell’ambito del progetto (1938-1940) per i padiglioni sull’Africa Orientale Italiana, come riproduzione dei Bagni di Fasilide, dal nome dell’imperatore etiope che fondò la città di Gondar nel 1632. Tuttora in Etiopia i fedeli si recano in visita al vero Castello di Fasilides, collocato nella parte sud dell’antica cittadella reale, per onorare il Timket, la festività principale della chiesa ortodossa copta, corrispondente alla nostra Epifania. Proprio la celebrazione di cerimonie religiose, che includevano l’immersione in acqua battesimale, era la funzione originaria di questo edificio. Curioso il fatto che l’originale etiope è ad oggi ben conservato, mentre la sua copia posticcia nella Mostra d’Oltremare, conosciuta appunto come Castello di Gondar, assomiglia a un fossile nonostante sia di tre secoli più recente.
LA CHIESA – Facendosi largo tra i simpatici e placidi tacchini, se si prosegue alle spalle del laghetto verso il Parco Robinson, si nota la presenza tra gli alberi di un insolito tempietto circolare, anch’esso ridotto a un fascinoso rudere che ha il (finto) sapore di altri tempi (remoti) e altri luoghi (esotici). Gli interrogativi si azzerano se si conosce il tema storico-geografico di questi giardini: non è altro che la replica di una chiesa copta, anch’essa tipica dell’architettura etiope e luogo sacro per l’ortodossia cristiana miafisita. La facciata esterna cilindrica presenta ancora le ventiquattro aperture ad archi, mentre è sparito il tetto a forma conica di un tempo, fatto di paglia e fascine. L’interno, per come appare oggi, è un labirinto concentrico che da diversi punti apre fughe curvilinee e rettilinee di archi e porte, tanto più fotogenici vista la parvenza di ruderi archeologici.
IL VILLAGGIO – In verità la chiesa era l’edificio maggiore di un intero villaggio abissino, che doveva stuzzicare la curiosità dei visitatori italiani emulando l’esteriorità architettonica e naturale, nonché la vita quotidiana di un intero nucleo abitativo tipico dell’oltremare africano, ovvero del territorio di conquista coloniale italiana.
Non lontano dai blocchi di cemento dei padiglioni in stile razionalista e funzionalista, questo villaggio scimmiottava, in forma dislocata e decontestualizzata, l’ambiente esotico delle colonie d’Africa: oltre alla chiesa copta e il Castello di Gondar costruiti con materiali giunti dall’Etiopia, le imitazioni includevano gli hudmò dell’altopiano etiope, i tukul della regione degli Amara, le tende dei nomadi della Dancalia e del bassopiano eritreo, infine le capanne alveari dei Cunama, tutti costruiti con paglia, argille, fango e tronchi d’albero. Lo spettacolo turistico comprendeva totem e altri oggetti sacri, animali esotici e flora trapiantata per replicare le ambientazioni d’origine: palme, acacie, euforbie, eucalipti, tamarindi, baobab, felci, ginepri e via dicendo (v. Aveta/Castagnaro/Mangone 2021).
In questa cornice ipnotica non poteva mancare una simulazione antropologica: all’interno del cosiddetto villaggio indigeno vivevano stabilmente 57 persone di diverse etnie originarie dell’Africa Orientale, allo scopo di esibire al pubblico scene di vita quotidiana, lavoro e artigianato tipiche dei territori coloniali. Non bastasse la loro esistenza ridotta forzatamente a una forma di cattività museale, gli ‘indigeni’ erano sorvegliati dalla PAI (Polizia dell’Africa Italiana) per impedire contatti con gli spettatori italiani, in forza delle leggi razziali.
Il villaggio indigeno era parte dell’opera edilizia che includeva il Cubo d’Oro (v. link in basso) e che fu realizzata da Zanetti, Racheli e Zella Milillo. Dopo i bombardamenti della seconda guerra, il villaggio fu per lo più distrutto. Nonostante un restauro del 1951, ne restano solo il laghetto con il Castello di Fasilides e la chiesa copta nello stato di ruderi: oggi sembrano misteriosi resti archeologici di una terra e di un’epoca lontane; invece, sono gli ultimi testimoni di una discutibile messa in scena antropologica, architettonica e naturalistica che integrò l’altrettanto ambiguo progetto espositivo della Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare.
Tipologia: museo naturale, architettonico, antropologico
Stato: abbandono, degrado
Dintorni: edifici coevi dismessi
Aggiornamento: marzo 2023
Speciale Mostra d’Oltremare
altri edifici
– Per il Padiglione Albania e il Salone dell’Impero, i cubi razionalisti della Mostra,
seguire questo link.
– Per l’approfondimento sul Padiglione Rodi e la Casa di Lindos, cliccare qui.